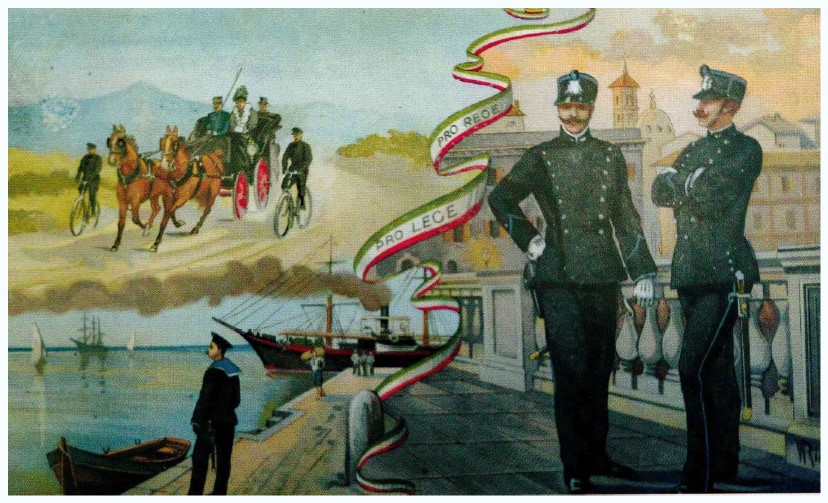Studi storici
A cura dell’Ufficio Stori o della Polizia di Stato
Commissario Giulio Quintavalli, Ispettore Fabio Ruffini, Assistente capo coordinatore Luca Magrone, e del Socio ANPS Massimo Gay.
Inserto alla rivista trimestrale delle Fiamme d’Oro Anno LI n.1Gennaio – Aprile 2024.
Prima parte.
Non immaginavo che la storia di questa terra, dove ho soggiornato per diversi periodi di vacanza, potesse essermi a tal punto sconosciuta. Leggendo numerosi testi ed esaminando i giornali dell’epoca emerge una regione povera ma molto fiera, che ha sempre rivendicato con estremo compiacimento il proprio passato dal carattere ribelle e sanguinario, enfatizzato e personificato in una figura simbolo: “il Passatore”,
l’ex traghettatore e brigante Stefano Pelloni, il cui viso barbuto, ancora oggi, occhieggia sulle etichette di noti vini romagnoli. Primo, per notorietà, di una serie di malfattori operanti in una regione non certo posizionata a sud, esponente di spicco di quel fenomeno “brigantesco” semisconosciuto in regioni più settentrionali, ma arcinoto in quelle meridionali. Rispetto al ricordo del bandito eroe, giustiziere dei torti subiti dalla povera gente, resistente contro la tirannide del governo e dei proprietari terrieri, diffuso tra i contadini del sud, quello emiliano-romagnolo ne mutuava solo il carattere della crudeltà, finalizzata al raggiungimento del suo unico scopo: il denaro.
I mezzadri e i contadini, loro obiettivi privilegiati, non importava se ricchi o poveri, ne erano terrorizzati. Il timore di rappresaglie, esercitato nei loro confronti, ne favoriva la latitanza, trasformando i malcapitati coltivatori e allevatori, vittime indifese qualora residenti in zone rurali isolate, in manutengoli (sostenitori) o fiancheggiatori.
A questo proposito, è emblematico l’episodio riferito da un giornale ravennate del 28 settembre 1865, dove si narra dell’assalto alla casa di un contadino da parte di una banda di quattro banditi che, non trovando nulla di valore da rubare, gli uccisero un figlio e gliene ferirono altri due.
Le scorrerie sanguinarie poste in essere da bande cospicue di malfattori che invadevano, occupando “manu militari” interi paesi razziandoli dei loro beni, rivivono, ancora oggi, in ballate e racconti orali. A seguito di ciò, per porre al sicuro gli averi della popolazione, si ebbe la tendenza alla proliferazione, come in nessun’altra regione italiana, di banche rurali e locali.
Gli anni che vanno dalla fine del brigantaggio, di pelloniana memoria, all’Unità d’Italia passarono lenti, colmi di sventure e tragiche calamità. Inondazioni e terremoti modificarono l’aspetto del territorio, specialmente quello della bassa ravennate; inoltre, epidemie di colera falcidiarono la popolazione. Dopo l’Unità d’Italia nulla cambiò, anzi per il popolo le condizioni peggiorarono; i “Piemontesi” portarono nuove tasse e servizio militare obbligatorio, di durata notevole. La leva obbligatoria istituita, nel 1860, dai Savoia era di otto anni, senza scappatoie se non quella di pagare una cifra molto rilevante. I giovani erano chiamati a servire lo Stato per molto tempo, sottraendo braccia all’agricoltura, all’artigianato e sicuro reddito alle famiglie che si impoverivano sempre di più. Inoltre, nuove tasse reclamavano denaro per l’Erario, depauperato dalle guerre sostenute per unificare l’Italia. Così alcuni, più esasperati di altri, si diedero al brigantaggio, altri ancora si costituirono in sette vincolate dalla segretezza e dall’omertà. Una tra le più famose fu quella degli “accoltellatori”, di connotazione e implicazioni prettamente politiche che, per lungo tempo, terrorizzò la provincia di Ravenna.
A quei tempi, il termine “accoltellatore” era usato per indicare genericamente tutti gli assassini che in quei luoghi (Romagne) si servivano prevalentemente del coltello o dello stile (stiletto). Col tempo la parola assunse una connotazione particolare, a designazione di omicida per motivi politici: non a caso era spesso abbinata anche alla parola “repubblicano”, usata dal governo monarchico per presentare questi ultimi come assassini sanguinari.
Il banditismo da strada e le sette furono rigogliosi in Romagna in ogni epoca, anche sotto il governo clericale. Già alla fine del settecento il popolo mostrava segni di ribellione nei confronti del clero e dei pochi latifondisti sfruttatori delle povere genti, i quali non reinvestivano i proventi in miglioramenti dei fondi o delle condizioni di lavoro.
Più tardi si era radicato il seme depositato dalla Rivoluzione francese; le idee di libertà, di democrazia e giustizia sociale avevano arricchito penetrando profondamente in un ambiente molto sensibile a quegli ideali politici. Le idee rivoluzionarie ribollivano come vino in fermentazione: lo dimostra il nutrito seguito di rivoltosi nelle sollevazioni popolari del 1831, del 1843 e del 1845.
Neanche lo Stato Pontificio, sostenuto dalle truppe austriache, e l’invio di vari cardinali, tra i quali il famoso Agostino Rivarola, erano riusciti, nonostante la cruenta repressione, ad addomesticare i rivoltosi carbonari.
Successivamente, il territorio delle Romagne alimentò per decenni il volontariato garibaldino e mazziniano. La Romagna, repubblicana, repubblicana e mazziniana, seguirà Garibaldi nelle sue spedizioni, anche in quelle antecedenti alla successiva unificazione. L’eroe dei due Mondi era considerato colui che armando il braccio avrebbe fatto la rivoluzione. Dire di quella regione che fosse un covo di repubblicani è la pura e semplice verità. Le popolazioni di quei territori, specialmente quelle delle cittadine portuali dedite a commerci legali, per sopravvivere si davano sovente al contrabbando e, per assicurarsi facilmente l’impunità, cercavano la corruzione dei Pubblici Ufficiali (Guardie Daziarie e di Pubblica Sicurezza). Coloro, tra questi, che non aderivano e si evidenziavano per il troppo zelo, venivano prima minacciati, anche per iscritto, se non addirittura uccisi.
In pubblico la gente sfuggiva ai contatti umani approfonditi con i dipendenti governativi, in particolare poliziotti e impiegati di Polizia, che erano considerati “appestati” venendo isolati dal resto della cittadinanza, sia per il timore che si potesse essere ritenuti dalla pubblica opinione informatori della Polizia, sia per le conseguenze che i malviventi potevano infliggere a coloro che li avvicinavano.
I BRIGANTI
La presenza di briganti nel territorio emiliano e romagnolo è attestata da documenti storici almeno fin dal Cinquecento. Sottoposte allo Stato della Chiesa, con parti del territorio controllate da altre entità confinanti (Granducato di Toscana, Legazioni di Bologna e Ferrara, oltre a territori in carico alle odierne Marche), le Romagne videro scorrere un flusso incessante di merci di contrabbando che alimentarono la piccola criminalità locale. Il salto di qualità, da contrabbandiere a brigante, non era scontato, ma la rete di potenziali manutengoli legata al traffico illegale, favorita dalla povertà endemica del territorio, era un fattore che poteva contribuire al proliferare di bande brigantesche, particolarmente attive nei periodi di crisi delle istituzioni. Bande che potevano sfruttare le zone ancora difficili da controllare come: le paludi della Bassa Romagna, i territori montani e quelli di confine tra Stati vicini, che adottavano legislazioni diverse, dove i briganti potevano fuggire in caso di inseguimenti o rastrellamenti. Nell ‘Ottocento i dati sui briganti sono molteplici e contribuiscono a ricostruire un quadro abbastanza preciso, a partire dall’età Napoleonica fino alla progressiva estirpazione del fenomeno, dopo I ‘Unità d’Italia.
Ecco un elenco, parziale, di briganti noti per le loro gesta, a partire dalla fine del Settecento:
• Sebastiano Bora, detto “Puiena”, attivo tra la Presidenza d’Urbino e la delegazione di Romagna;
• Tommaso Rinaldini da Montemaggiore (Urbino), detto “Mason d’Ia Bolna” (Tommaso dell’Isabellona), che succede a “Puiena”, insistendo grosso modo sul suo territorio. Numerosissimi i briganti attivi durante i primi momenti dell’invasione napoleonica. La situazione si stabilizza nel 1802, ma dal 1805 il fenomeno ricompare;
• Michele Botti, detto “Falcone”, attivo nelle zone intorno a Bagnacavallo. La sua carriera termina durante lo scontro a fuoco con le forze dell’ordine alle 9,00 del 14 maggio 1810, in Fondo Roncorosso a Bagnara. Dopo la Restaurazione il fenomeno, endemico, del brigantaggio prosegue in sordina;
• Antonio Cola, soprannominato “Fabrizj”. Ѐ il delinquente dalla carriera più lunga tra i briganti che hanno agito anche in territorio romagnolo. La sua zona di azione, tuttavia, andava da Saludecio a S. Giovanni in Marignano, Gallo di Pesaro, Carpegna Fano. Per alcuni anni anche in Umbria, fino, a Gubbio e addirittura a Todi;
• Stefano Pelloni, detto “il Passatore”, che viene ucciso il 23 marzo 1851. Gli succede Giuseppe Afflitti, di Cantalupo di Imola, detto “Lazzarino”;
• Gaetano Prosperi di Lognola, detto “Lo Spirito”, morto nel 1865, molto noto ancora oggi come “11 brigante del Papa Re”, contestatore della leva, probabilmente di sentimenti clericali;
• Luigi Casadio, detto “Gaggino” per via dei suoi capelli rossi, che in camicia rossa e con due crocefissi al collo derubava e uccideva i passanti nelle campagne intorno Ravenna.
L’AMMONIZIONE E IL DOMICILIO COATTO
Per cercare di arginare il fenomeno del brigantaggio e della delinquenza in genere, furono emanati provvedimenti eccezionali, approvati dal Governo con la Legge n. 294 del 6 luglio1871. Questi erano, tra gli altri, l’ammonizione e il domicilio coatto. Con tale provvedimento, furono delineate meglio due figure già presenti nell’ordinamento, dandogli valenza giuridica: l’oziosità e il vagabondaggio.
L’ammonizione si applicava a seguito della denuncia scritta dell’Autorità di P.S., ” … ovvero anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà…”. Il magistrato poteva chiamare a sé il vagabondo o l’ozioso e con lo spauracchio dell’arresto, da tre a sei mesi, se non avesse obbedito, lo ammoniva a darsi im- mediatamente a stabile lavoro e, nel contempo, l’obbligava a non allontanarsi dalla località di dimora senza comunicazione all’Autorità di P.S. Se non cambiava atteggiamento il magistrato gli comminava l’ammonizione.
Per realizzarsi l’oziosità dovevano concorre re tre elementi, cioè che l’imputato fosse:
• sano e robusto, abile al lavoro;
• non provveduto di sufficienti mezzi di sussistenza, non in grado di vivere senza lavorare;
• non dato a stabile lavoro, dal quale possa ricavare i mezzi di sussistenza.
Realizzandosi queste tre circostanze l’imputato era legalmente ozioso, e si presumeva che vivesse di mezzi illeciti, “…cioè coi pro venti del giuoco o del lenocinio o della frode o del furto, e quindi lo annovera fra le persone pericolose per la Sicurezza Pubblica o lo punisce coll’ammonizione”. A costituire il vagabondaggio dovevano concorrere tre elementi, cioè che l’imputato fosse:
• senza domicilio certo, vale a dire senza un’abitazione nella quale abitualmente dimori, perché non basta che abbia un domicilio legale, o una casa in cui non abiti;
- senza mezzi di sussistenza, non in grado di vivere senza lavorare;
• senza l’esercizio abituale di un lavoro realmente sufficiente a procurargli i mezzi di sussistenza.
Concorrendo questi tre elementi l’imputato era legalmente vagabondo, quindi: “… la Legge presume che, come l’ozioso, viva di mezzi illeciti, lo annovera fra le persone pericolose per la Sicurezza Pubblica e lo punisce col carcere”.
Ne conseguiva che: “… i vagabondi dichiarati legalmente sono puniti con tre mesi di carcere, mentre gli oziosi soggiacciono alla stessa pena solamente quando abbiano contravvenuto a una precedente ammonizione
L’invio al domicilio coatto, rispetto all’ammonizione, era un provvedimento esclusivamente amministrativo, subordinato per legge, alla condanna per contravvenzione dell’ammonizione, infatti: “Il Prefetto nell’interesse dell’ordine e della Sicurezza Pubblica, può sempre vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire il domicilio nella città o altri luoghi da lui scelti dopo che ha finito di espiare la pena”.
Con la nuova formulazione il domicilio coatto si doveva applicare, dal Ministero dell’Interno, per gravi circostanze di sicurezza e ordine pubblico, contro l’ozioso e il vagabondo già condannati, per un periodo di sei mesi fino a due anni. E da un anno a cinque anni sempre per le medesime figure, se recidive.
Infine, ai sensi dell’art. 105 della Legge sulla Pubblica Sicurezza, le medesime fattispecie si potevano applicare anche alle persone sospette “… come grassatori, ladri, truffatori, borsaioli, ricettatori, manutengoli, camorristi, mafiosi, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini e per delitti contro le persone e la proprietà.
In antitesi alla legge vigente all’epoca, esimi studiosi affermavano che “… non si deve punire l’intenzione, il sospetto o la capacità del reato commesso” Secondo i detrattori di tale sistema, invece, il domicilio coatto era una istituzione sbagliata ma l’applicazione non potrebbe essere peggiore, inoltre non si può considerare come ulcera benigna da potersi guarire con mezzi terapeutici, ma come cancro da estirparsi col ferro, se si ‘vuole offrire al corpo sociale ammalato l’unico modo di risanare”.
Fine prima parte.